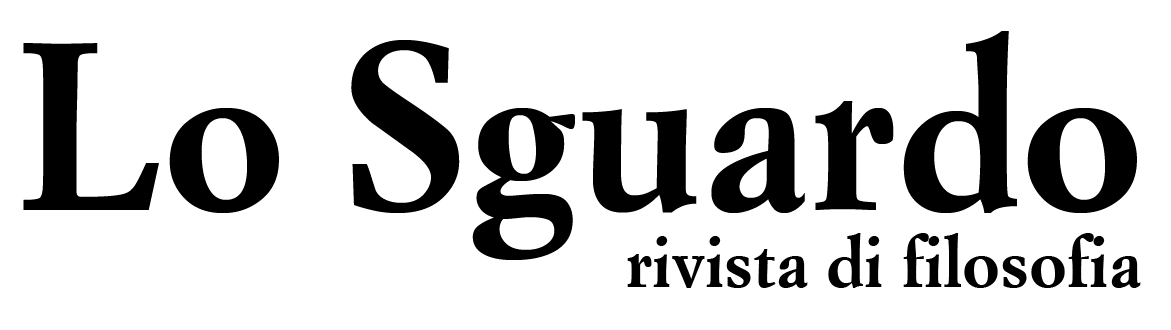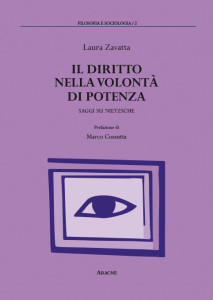RECENSIONI / Daniele Cavarra /
L’aspetto giuridico e politico della filosofia di Nietzsche è certamente uno degli argomenti oggi più interessanti e discussi dagli studiosi del filosofo tedesco. A questo tema ‒ e alla sua attualità ‒ è dedicato il nuovo libro di Laura Zavatta. Il testo è composto, infatti, da sei saggi alcuni dei quali già in passato dati alle stampe, che l’autrice ha rivisto e ampliato per l’occasione e che ruotano intorno alla teoria nietzschiana dello Stato e del fenomeno giuridico-morale. Dal punto di vista teorico, la posizione di Nietzsche circa la nascita dello Stato e del diritto è connotata da un radicale rifiuto del modello contrattualista e da un altrettanto deciso rifiuto della teoria giusnaturalistica. Come fa notare l’autrice, infatti, benché Nietzsche condivida la descrizione hobbesiana della sfera pre-politica della socialità, diverge poi radicalmente dal paradigma del contratto inaugurato dal filosofo inglese; così, il fatto «che lo stato abbia inizio con un “contratto”, per Nietzsche, è solo una “fantasticheria” da liquidare, poiché il dominio pubblico, per il filosofo di Röcken, è imposto e stabilito da chi comanda, da chi è signore per natura e procede con la forza nell’opera e nei comportamenti» (p. 22). Ciò implica naturalmente che il diritto positivo, espresso dal potere statale, non possa essere considerato mai «assoluto e indiscutibile, così come pretende di sostenere la tradizione; viceversa, come si è detto, risponde alla necessità di consolidare e perpetuare i rapporti di potenza altrimenti momentanei» (p. 24). Queste riflessioni così dure che riconducono, come si vede, la sfera del diritto a meri rapporti di potenza vanno lette alla luce di un grande tema della filosofia nietzschiana: il nichilismo. L’affermazione nietzschiana “Dio è morto”, infatti, non è solo un’asserzione ontologica sulla non esistenza di Dio ma riguarda qualcosa di ancora più decisivo, poiché esprime il dato di fatto inconfutabile della modernità, vale a dire l’impossibilità di credere ancora in qualsiasi tipo di struttura assoluta e oggettiva della realtà. Essa non indica dunque solamente la crisi della fede in Dio quale Essere supremo e trascendente ma esprime altresì la perdita della fede nella stabilità e nella razionalità della realtà in generale. La morte di Dio implica, di conseguenza, anche un cambiamento profondo del rapporto fra l’uomo e il mondo. Su quest’ultimo, l’uomo ha proiettato spesso inconsapevolmente, per millenni, i suoi schemi interpretativi che ora, nella modernità, si mostrano per ciò che sono: ipostatizzazioni arbitrarie del reale. La scoperta di tutto ciò è una dolorosa presa di coscienza epocale che sul piano morale-giuridico si traduce nell’impossibilità di esibire un fondamento oggettivo, universale e necessario del diritto, il quale, non possedendo più autonomia rispetto alla dimensione storico-empirica, finisce per coincidere con l’arbitrio della volontà umana storicamente determinata; in termini nietzschiani potremmo dire che esso diviene la proiezione di una volontà di potenza.