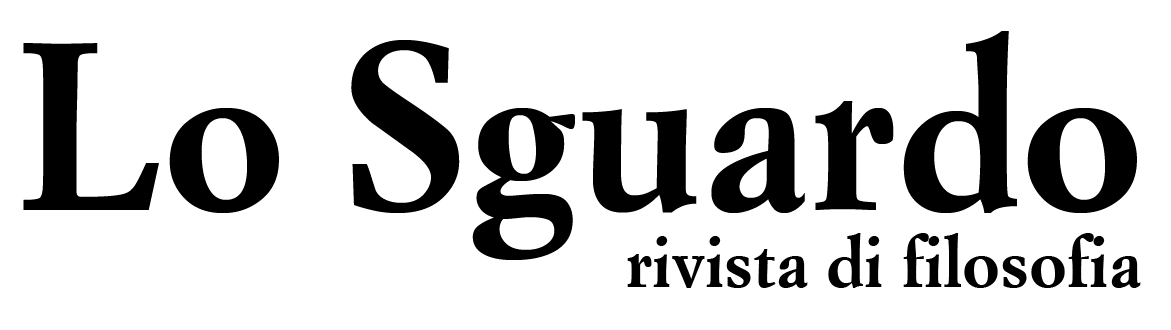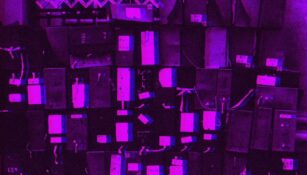RECENSIONI / Giulio Piatti /

C’è un termine che ricorre spesso nell’ultimo libro di Pierre Montebello, Métaphysiques cosmomorphes. La fin du monde humain (Les presses du réel 2015): arpenter. Si tratta di un verbo che indica al tempo stesso sia la misura della superfice di un terreno ‒ attraverso l’arpent, l’acro ‒ sia l’atto di percorrere con passo deciso un luogo. Meglio di qualsiasi definizione, questo termine ci permette di cogliere, in medias res, il cuore del saggio, ovvero il tentativo di ricomprendere filosoficamente il classico problema dell’uomo nel suo rapporto con il mondo. Cosa significa, oggi, ‘fare mondo’? In che modo è possibile tracciare (quindi misurare e percorrere, arpenter) un piano comune che dia conto di tutti gli esseri, viventi e non, che popolano la terra? Quale sarà il posto dell’uomo all’interno di un cosmo così radicalmente ridefinito?
Non sarebbe difficile mostrare – ed è Montebello stesso a confermarlo ‒ come un tale approccio sia prossimo alle tematiche affrontate dal cosiddetto postumano, nell’interrogare radicalmente il ruolo dell’uomo nella contemporaneità. In effetti, gli autori a cui Montebello si rifà sono, a loro modo, protagonisti di un certo filone francese del postumanismo, da Deleuze e Guattari a Foucault, da Simondon a Latour, da Isabelle Stengers a Viveiros De Castro. Al di là delle sirene di un facile e pacificato umanismo filosofico, sempre più preoccupato dal rischio dell’estinzione di homo sapiens e del suo naturale impero sulle cose, il discorso postumanista sembra infatti liberare un grande potenziale teorico, capace di ricalibrare le ormai porose frontiere tra dato naturale e dato culturale.
Ciò che però non sembra permettere un corretto orientamento delle indagini postumanistiche è, secondo Montebello, il cosiddetto anthropocenic turn, ormai potentemente presente nelle scienze umane grazie alle ipotesi formulate dal chimico Crutzen, dal microbiologo Stoermer e dal climatologo Stevens, secondo i quali siamo entrati, con la rivoluzione industriale, in una nuova era geologica nella quale l’attività umana è divenuta la principale causa delle trasformazioni geologiche del pianeta. Secondo Montebello l’ipotesi dell’antropocene rientra in quello stesso umanismo che vorrebbe denunciare, costituendone anzi la più paradossale amplificazione: l’uomo si trasforma infatti in una vera e propria forza tellurica, unico protagonista di una narrazione ineluttabile che lo ha reso, da cacciatore-raccoglitore, una formidabile variante geologica. La caratura apocalittica di molte filosofie che si rifanno oggi all’ipotesi dell’antropocene rileva così un’equivocità del termine, che oscilla costantemente tra funzione descrittiva e prassi prescrittiva. Il percorso ineluttabile dell’eccezione umana, che non rende conto di tutta una parte dell’umanità non partecipe di questo percorso né della contingenza storica delle scelte tecniche, fa qui il paio con la sommersa carica di morte, un’ossessione quasi nevrotica verso la fine del mondo che trasforma così l’antropocene in un macabro «tanatocene» (C. Bonneuil, J. B. Fressoz, L’événement anthropocène, Seuil 2013).
Per organizzare in modo produttivo un discorso realmente postumanista, occorre allora ritornare preliminarmente alla storia della filosofia, per verificare in che modo si sia potuto costituire un umanismo così totalizzante, incapace cioè di uscire dal racconto dell’essere umano come eccezione. Montebello si riferisce qui innanzitutto a Kant e alla sua definitiva delimitazione della metafisica all’intendimento umano (p. 20) e alla conseguente distinzione della conoscenza possibile dall’in sé noumenico: con Kant la metafisica si trasforma, da disciplina teoretica, in una scienza dei limiti, interna al ristretto ma legittimo campo del ‘tribunale della ragione’. Egli porta così a compimento un percorso che, dal dualismo cartesiano, approderà, non senza inquietudini, fino a Husserl, ovvero al progressivo innalzamento del correlazionismo a supremo garante filosofico: non si avrebbe accesso al reale che attraverso la correlazione di pensiero e essere, non si potrebbe fare filosofia che a patto di partire preliminarmente dallo schema soggetto-oggetto. L’impresa di gran parte del pensiero occidentale moderno sarebbe allora quella di aver individuato con rigore il campo dell’esperienza possibile, circoscrivendo una serie di limiti tra assoluto e relativo, uomo e animale, biologia e fisica, natura e cultura, qualità prime e seconde.
Dal ‘passo di danza correlazionista’ si sono esplicitamente distaccati Alain Badiou e, più recentemente, il suo allievo Quentin Meillassoux, a cui Montebello dedica un’approfondita disamina. Rompendo con i rigidi limiti fissati da Kant, entrambi si sono indirizzati, in modi ovviamente differenti, verso un’ontologia formale di natura matematica, in grado di cogliere gli oggetti in loro stessi, prima e indipendentemente dall’azione umana. È infatti la scienza matematica a poter garantire un accesso al reale non più mediato dai limiti strutturali del soggetto conoscente: dall’eccezione umana di marca kantiana si passerebbe così, significativamente, a una sorta di epoché del soggetto stesso. Montebello mostra bene quanto il vizio interno a queste due tradizioni di pensiero, all’apparenza opposte, stia in una comune svalutazione del concetto di ‘mondo’ in quanto problema filosofico: da un lato la linea Kant-Husserl sembrerebbe avviarsi verso un’inesorabile denaturalizzazione della coscienza, unico filtro di accesso al mondo, dall’altro il campo dei ‘nuovi realismi’ (dal realismo speculativo all’Object-oriented theory, passando per la Flat ontology) porterebbe alla simultanea scomparsa di uomo e mondo, in favore di un insieme ideale di oggetti in sé, conoscibili e ‘anticipabili’ matematicamente all’interno di un contenitore vuoto e neutro (cfr. M. Gabriel, Perché non esiste il mondo, Bompiani 2015).