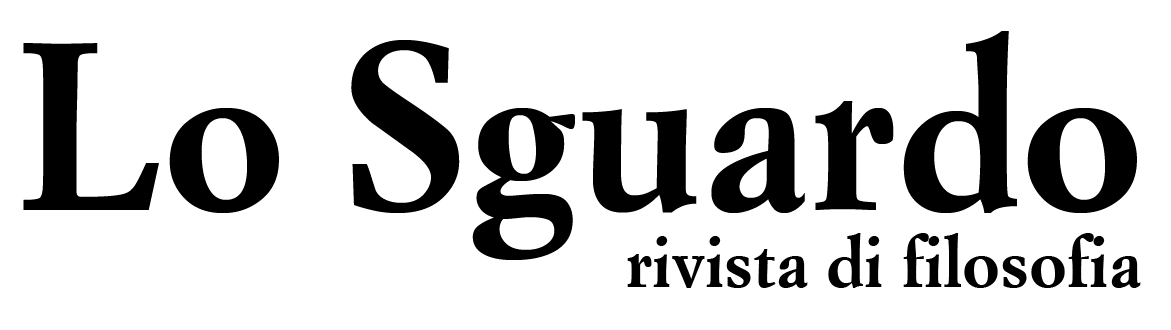DISCUSSIONI / Lorenzo Coccoli
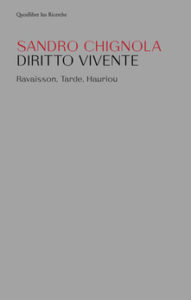
Inferno, canto XXIX. Dante è con Virgilio nella bolgia dei falsari. Gli si presenta allora l’ombra di tale Capocchio – sprofondato nel tormento eterno per aver manipolato «li metalli con l’alchimia» – e, proprio prima che il canto dilegui, offre al poeta gli strumenti per una possibile agnizione: «e te dee ricordar, se ben t’adocchio / com’io fui di natura buona scimia». L’orgoglio evidente con cui l’ultima battuta è pronunciata contrasta con la terribilità del luogo e della punizione a cui Capocchio è sottoposto. Quasi che nel suo personaggio – o meglio, nella contraddizione performativa tra la fierezza delle sue parole e il corpo piagato dalla «scabbia» – si venissero ad allacciare in equilibrio instabile due diverse tradizioni concettuali relative al tema dell’imitazione. Da un lato, la condanna platonica (e classica) della mimesis, ridotta a operazione di ‘scimmiottamento’ dell’Idea prodotta in natura dal dio (Rep., X, 597b), e quindi allontanamento dalla purezza del mondo noetico in direzione dell’infida mutevolezza delle apparenze fenomeniche. Dall’altro, la linea ellenistico-romana dell’aemulatio, della ripetizione differenziale dell’originale greco, il cui ‘prestigio’ abilita la maestria dell’aemulator che lo ri-produce, e che riproducendolo però lo ri-forma. In una battuta: il primo indirizzo affiora nel sostantivo, la «scimia», il secondo nell’aggettivo che lo qualifica, «buona». Passività meccanica versus ri-attivazione virtuosistica: è questo, benché condensato in termini idealtipici, il senso dell’opposizione di fondo.