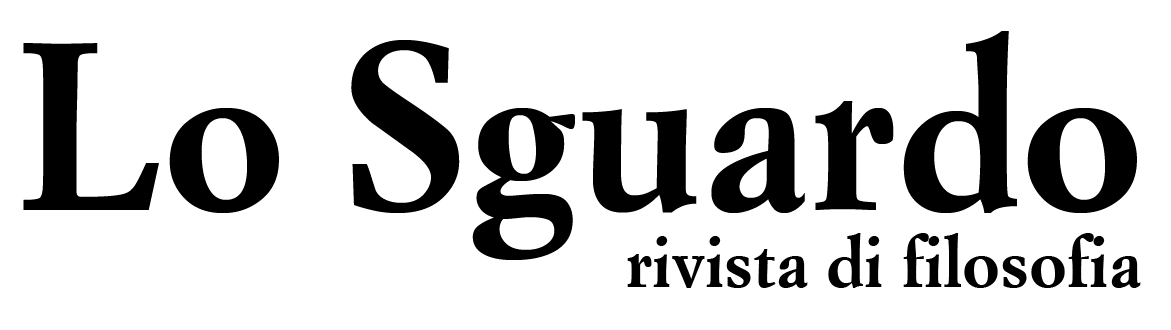RECENSIONI / Giulia Andreini /

Traccia, engramma, scoria, reminiscenza: molti sono i nomi con i quali si è storicamente tentato di cogliere l’ineffabile essenza della memoria. A contraddistinguerla è, tuttavia, la sua intrinseca fallacia, che ne è tratto fondamentale: la compresenza di presente e passato, presenza e assenza, immanenza e trascendenza. Come ricorda Maurice Merleau-Ponty nel corso sulla Passività (1954-55), riecheggiando la celebre disamina proustiana, la memoria è iscrizione di una traccia e, al contempo, la sua cancellazione, oblio che è sempre possibilità di riattivazione.
Una condizione peculiare, quella della memoria, che sembra subire la minaccia di una possibilità di archiviazione digitale potenzialmente inesauribile, sebbene permanga il dubbio che l’in-saturabilità della memoria macchinica possa essere, per l’appunto, un mito. A incombere è la minaccia del Funes borghesiano, oltre-uomo dalla prodigiosa capacità ritentiva, in grado di ricostruire persino sogni e dormiveglia. Un’illimitata coscienza tetica il cui rovescio della medaglia altro non è che l’erosione di un qualsiasi orizzonte di trascendenza: una temporalità intrinsecamente a-temporale, dove passato-presente-futuro collassano in un eterno ora e in cui la rimemorazione perde di consistenza – scevra, ormai, dall’oblio che la costituisce –, costantemente in procinto di coincidere con l’atto percettivo.